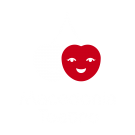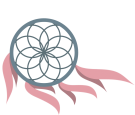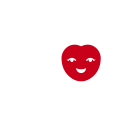NOTE DI REGIA
Coi pesci per aria e le foreste ambulanti,
e i fichi che spuntavano dai rovi, in un attimo di luna cruenta
fu allora che venni fuori.
La testa mostruosa e il verso ripugnante,
ali erratiche le orecchie, diabolica parodia ambulante di ogni quadrupede.
Cencioso proscritto del mondo,
vecchia capoccia ostinata;
affamami, frustami, deridimi: son muto, il mio segreto lo tengo per me.
Pazzi! Che anch’io ho avuto la mia ora;
un’ora ah dolce e fiera:
sentivo grida nelle orecchie,
e le palme sotto i piedi.
(L’asino, G. K. Chesterton)
L’idea dell’ostinato essere l’abbiamo incontrata studiando Pinocchio. Agamben, nel suo commento al libro di Collodi, scrive: “«Andare avanti» definisce invece la vocazione di un essere – il burattino – che ha ostinatamente da essere il suo modo di essere”. Vedere Pinocchio come un ostinato, come qualcuno che non può che essere il suo modo di essere, ci ha permesso di individuare il nucleo che ci premeva raccontare. Il mondo è pieno di esseri ostinati. Ostinato è chi risponde a una vocazione nonostante tutto e chi invece insegue la propria natura. In un caso o nell’altro, la vita degli ostinati è costellata di ostacoli. Ostinarsi significa affrontare il dolore e la solitudine sperando di raggiungere la liberazione. Quello che vogliamo raccontare è il viaggio – controvento – di chi convive con il proprio ostinato essere e con le conseguenze di questa condizione.
Proverbiale è l’ostinazione dell’asino. Non solo per questo, però, la nostra protagonista umana convive con una natura asinina. L’asino è una figura misteriosa e malinconica. Cugino minore del più elegante cavallo, ammantato nella sacra aura del ridicolo, questo animale attraversa la nostra cultura: pensiamo all’Asino d’oro di Apuleio, ad esempio, e ovviamente allo stesso Pinocchio, ma anche ai proverbi contadini o alla celebre poesia di Chesterton, che ci ricorda che non a caso Gesù fece il suo ingresso a Gerusalemme proprio sul dorso di un asino. Abituato a portare grandi pesi, questa figura ci è sembrata quella che più di tutte potesse incarnare l’ostinato essere in ogni sua sfumatura.
In scena si alternano allora una figura umana e un asino antropomorfo dando vita a una sequenza di immagini ispirate da queste domande: vale la pena? Tutto il dolore che costa questo forsennato inseguirsi, vale la pena? Ci sarà una liberazione alla fine di questa sofferenza?
Queste domande le abbiamo sentite riecheggiare nelle discussioni avute con amici e amiche. Sono domande che vivono in noi. Se le generazioni precedenti si sono ritrovate nel motto deandreiano in direzione ostinata e contraria, la nostra sembra essere la generazione dell’ostinato essere, di chi, al di là della direzione, deve lottare anche solo per essere.
Entrando nel vivo del lavoro scenico, data la presenza della maschera, abbiamo deciso di sottrarre la parola e di lasciare più spazio possibile al corpo e alla fisicità. È stato indispensabile perciò lo sguardo e il lavoro di Luca Piomponi, danzatore che ha curato il movimento scenico e ha permesso al lavoro fisico di svilupparsi nella maniera che desideravamo. Un lavoro che oscilla tra il mimetico e l’astratto continuamente, in cui un’azione riconoscibile può diventare irriconoscibile e un’azione astratta può trasformarsi in un gesto leggibile. Giocando con queste escursioni si sono delineati i fili della nostra drammaturgia scenica.
Altra collaborazione fondamentale è stata trovata con la costume designer e artista visiva Giulia Cauti. Sua è la scultura scenica che appare nel finale e che concretizza la parabola del nostro lavoro.
Un ultimo accenno all’utilizzo della musica, una selezione dei Capricci di Niccolò Paganini. Un ostinato essere anch’egli, senza dubbio, le cui composizioni per violino sono un apice di virtuosismo e poesia. Un violinista che suona per quattro è sicuramente un miracolo, ma ci si conceda di ritrovare, in tutto questo, una punta di malinconia e di solitudine. Immaginiamo così gli ostinati esseri: presi a metà tra il virtuosismo di un’esistenza ostinata e la solitudine di non poter condividere con nessuno la propria croce.
Andrea Milano Spartenza Teatro